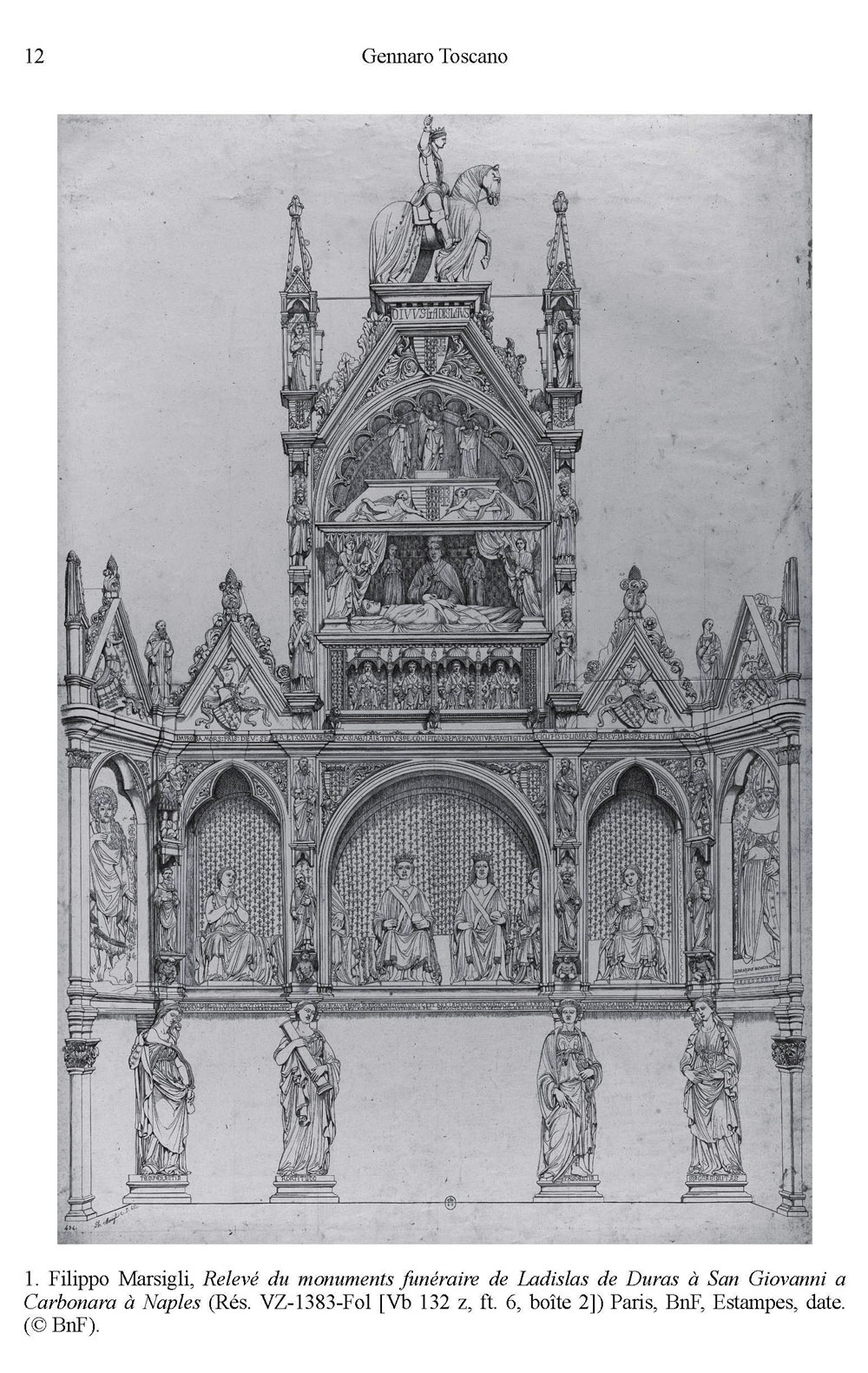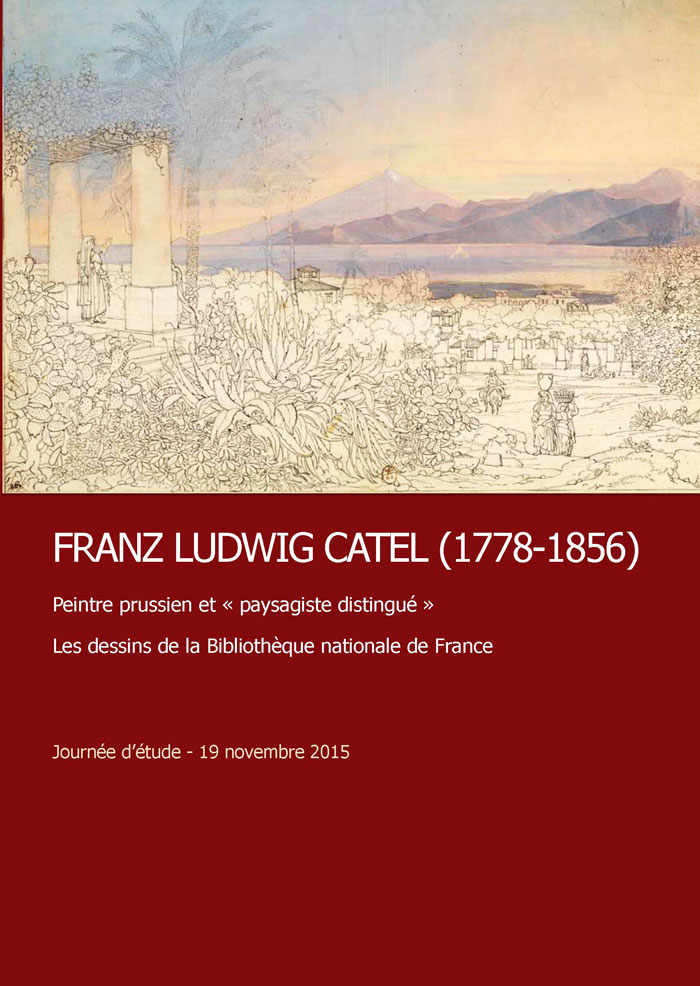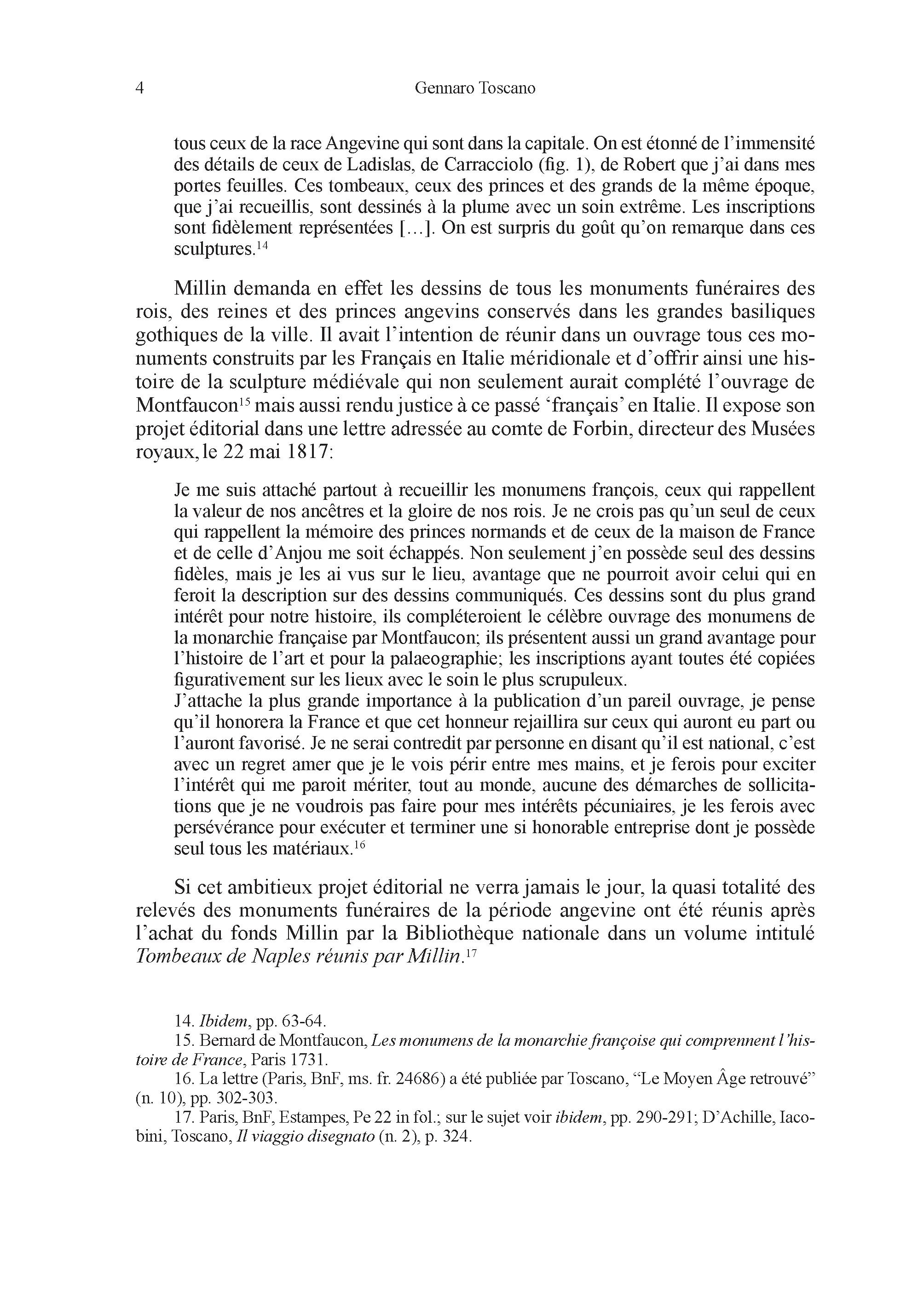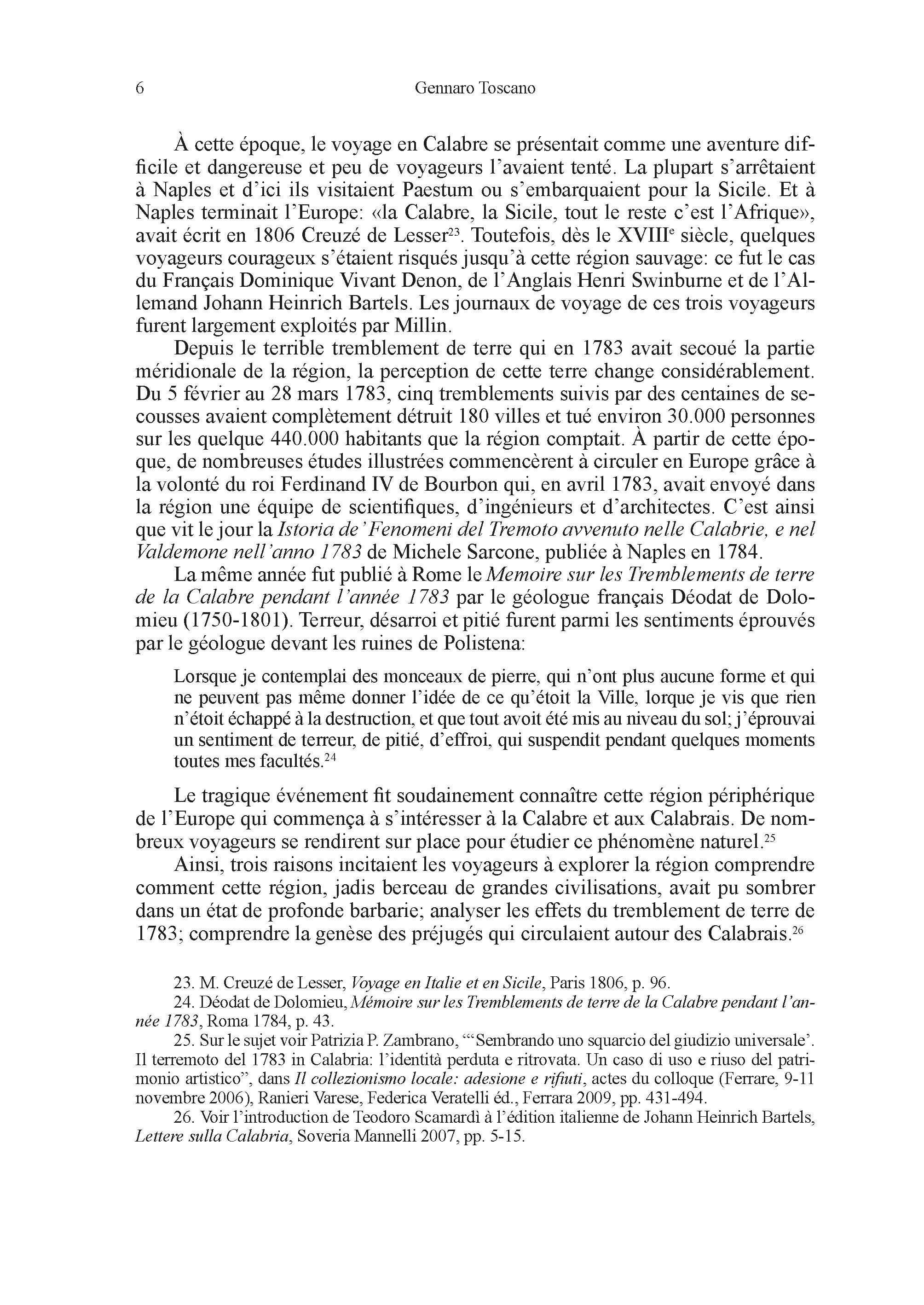di A.M. D'Achille - Enciclopedia dell' Arte Medievale (1998)
PIETRO di Oderisio
Scultore romano appartenente alla famiglia di tradizione 'cosmatesca' degli Oderisi (Claussen, 1987), attivo alla fine del 13° secolo.
La messa a fuoco di questo artista è assai problematica sia per la mancanza di documentazione storica sia, soprattutto, per il pessimo stato di conservazione delle opere che gli sono attribuite sulla base di epigrafi per lo più mutile o perdute. Il numero delle sculture che ruota attorno al nome di P., così come l'arco cronologico e geografico della sua attività, è inoltre molto ampio, tanto che, se l'autografia dei monumenti fosse dimostrabile con sicurezza, nel marmoraro romano andrebbe ravvisata una delle principali personalità artistiche di fine Duecento.
Punto di partenza per la ricostruzione dell'attività di P. è il monumento funebre di papa Clemente IV (m. nel 1268), attualmente nel braccio sinistro del transetto di S. Francesco alla Rocca a Viterbo, ma originariamente collocato nella chiesa viterbese di S. Maria di Gradi, quasi unanimemente attribuito all'artista sulla base della testimonianza di Papebroch (1688); questi, fornendo la prima ampia descrizione del sepolcro, cita la scritta che si trovava sul fondo, sotto la curvatura dell'arco, "Petrus Oderisii sepulchri fecit hoc opus", già allora solo parzialmente leggibile e andata poi distrutta. La testimonianza successiva, degli inizi del sec. 18°, quella della Cronologia Gradensis, attribuita a Francesco Maria Salmini, identifica invece nel Petrus della scritta il presunto committente dell'opera, Pietro di Montbrun, arcivescovo di Narbona.Il monumento di Clemente IV costituisce un punto di snodo fondamentale nello sviluppo della tipologia sepolcrale in Italia, giacché presenta elementi innovativi come la struttura a baldacchino, la figura giacente e la contrapposizione iconografica tra la morte e la vita eterna che doveva essere rappresentata sulla parete di fondo; alla scelta di questo tema non dovette essere estraneo l''ambito domenicano' in cui l'opera fu prodotta (Monferini, 1969). Oggi il sepolcro - dopo una serie di complesse vicende che ne hanno profondamente alterato la struttura (D'Achille, 1990) - si presenta composto da un basamento mosaicato a motivi cosmateschi con due pilastrini esagonali agli angoli; da un sarcofago di reimpiego - che attualmente mostra la fronte romana un tempo poggiata alla parete, ma che originariamente presentava anch'esso la decorazione a dischi e mosaici andata quasi completamente distrutta durante la seconda guerra mondiale - su cui è posta la figura del pontefice dal volto realistico di straordinaria intensità, realizzato forse su una maschera funebre (Keller, 1935); da un baldacchino trilobo archiacuto con gattoni, anteriormente sostenuto da due colonnine decorate 'a spina di pesce', che poggiano sui pilastrini ai lati del basamento; infine, dal sarcofago con un'altra figura giacente, identificata con il nipote del pontefice, Pierre Le Gros, generalmente considerata un'aggiunta posteriore di alcuni decenni. Del sepolcro, secondo Claussen (1987), doveva far parte, per lo meno nel progetto iniziale, anche un leone proveniente da S. Maria di Gradi, da assegnare dunque a P. (Viterbo, Mus. Civ.).La datazione del monumento è problematica per la complessa vicenda del seppellimento del pontefice, conteso tra i Canonici della cattedrale e i Domenicani di S. Maria di Gradi, che si risolse definitivamente solo nel 1276. I documenti spesso contraddittori di quegli anni non autorizzano conclusioni definitive, ma in via ipotetica l'opera si può collocare intorno alla metà degli anni settanta (D'Achille, 1989; 1996).Il fatto che si debba proprio a P. - appartenente a una di quelle famiglie di marmorari romani specializzati solo nelle produzione di suppellettile liturgica (v. Cosmati) - l'introduzione in Italia sia del baldacchino gotico sia della figura giacente (oltretutto in una rappresentazione realistica ancora sconosciuta in Europa) costituisce effettivamente un problema critico complesso. Se Bauch (1971; 1976) lo risolse attribuendo a P. solo il sarcofago e ad Arnolfo tutte le altre parti (un'ipotesi questa decisamente respinta da Romanini, 1969; 1983; 1986), la maggior parte della critica (a partire da Rossi, 1889) ha spiegato le 'novità gotiche' con un viaggio dell'artista in Inghilterra, avvenuto forse dopo un passaggio in territorio francese, identificando in lui il firmatario dell'arca di Edoardo il Confessore (m. nel 1066) a Westminster.
Di fatto nell'abbazia di Westminster - ricostruita da Enrico III a partire dal 1245 come chiesa dell'incoronazione e sepolcreto della famiglia reale inglese - esiste un gruppo di opere collegabili all'attività di maestri romani, reclutati personalmente, durante i suoi viaggi in Italia, dall'abate Richard de Ware, che, come si legge sulla sua tomba nella stessa abbazia, importò lapides de Urbe. Si tratta del pavimento del presbiterio di fronte all'altare maggiore, che reca la firma Odericus; dell'arca che doveva sostenere un grande scrigno con le reliquie di Edoardo il Confessore, siglata da un Petrus qualificato come Romanus civis, e del monumento funebre di Enrico III (m. nel 1272).
L'arca di Edoardo, voluta da Enrico III, fatta demolire da Enrico VIII e ricostruita negli anni 1556-1560, si presenta oggi come un imponente parallelepipedo con tre lati aperti da profonde nicchie trilobe e archiacute (che nella parete di fondo presentavano una ricca decorazione cosmatesca), al di sopra delle quali corre una fascia orizzontale a specchi rettangolari, spartiti geometricamente in dischi e rombi raccordati da fasce musive; il quarto lato è costituito da una lastra rettangolare (forse quanto resta dell'altare; Perkins, 1938, p. 18), con analoga decorazione geometrica e musiva; agli angoli colonnine tortili sostengono un architrave aggettante.Attualmente le analogie che quest'opera presenta con il monumento viterbese si limitano ad alcuni dettagli quali il motivo 'a cinghia di trasmissione' (Claussen, 1987; 1990), presente all'interno delle nicchie del monumento di Edoardo e nel basamento del sepolcro papale, dove peraltro i rapporti proporzionali sono leggermente diversi, e all'uso della decorazione a chevron (forse repertorio comune di motivi cosmateschi; Binski, 1990). Nella struttura complessiva i due monumenti sembrano invece molto diversi ed è possibile, come sottolineano Gardner (1973; 1990; 1992) e Binski (1990), contrari all'identità tra i due artisti, trovare non a Roma, ma in Inghilterra i precedenti tipologici dell'opera di Westminster.
Di fondamentale importanza per l'identificazione del Petrus di Westminster con P. sarebbe anche la collocazione cronologica dell'arca, che è a tutt'oggi una questione aperta (Gardner, 1973; 1990; 1992; Claussen, 1987; 1990). Infatti, l'iscrizione in lettere romane intarsiate in vetro blu, che un tempo correva sulla fascia della cornice, oggi non è più visibile se non per pochi frammenti; se la lettura diffusasi dal sec. 18° e generalmente accettata ("Anno milleno Domini cum sexageno et bis centeno cum completo quasi deno hoc opus est factum quod Petrus duxit in actum Romanus civis"), che riferisce l'opera di P. alla fine degli anni sessanta, potrebbe trovare conferma nella traslazione delle reliquie di s. Edoardo, avvenuta il 13 ottobre 1269, e nella consacrazione della nuova abbazia nello stesso anno, la versione riportata nel sec. 15° da Richard Sporley, monaco di Westminster e storico degli abati e dei priori della casa, con la variante septuageno al posto di sexageno (Londra, BL, Cotton Claud. A. VIII, c. 59v), che sembra spostare la datazione del monumento di un decennio (Binski, 1990), riapre la discussione. Su quest'opera peraltro tacciono i documenti, abbastanza esaurienti sulle altre commissioni artistiche di Enrico III (Building Accounts, 1971), e invece ancora nel 1290 è documentato un pagamento per tre colonne di marmo (Binski, 1990).
Anche per il sepolcro di Enrico III - collocato per volontà dello stesso re di fronte all'arca di Edoardo il Confessore e costituito da un largo basamento, che presenta nel lato che guarda l'arca tre aperture, sopra al quale è posto uno stretto sarcofago, ornato da lastre di porfido e dai consueti motivi cosmateschi, dove nel 1291 fu posta l'effigie del defunto - è stato fatto il nome del marmoraro romano. Monferini (1969) ipotizza una sua realizzazione da parte di P. negli stessi anni dell'arca di Edoardo (intorno al 1269); Claussen (1987; 1990), sulla base di dati documentari e del confronto stilistico con il monumento funebre di Adriano V nel S. Francesco alla Rocca di Viterbo e con l'altare del Presepe di Arnolfo in S. Maria Maggiore a Roma, riferisce l'opera a una seconda ondata di influsso romano, distante dalla prima di circa un ventennio e direttamente collegata alla bottega di Arnolfo, a capo della quale, poté essersi trovato ancora una volta P.; Binski (1990), infine, seppure in termini più sfumati non esclude l'attribuzione.
L'ipotesi di un'attività di P. all'interno della bottega di Arnolfo è in ogni caso legata all'iscrizione "+Hoc opus/fecit Arnolfus/cum suo soci/o Petro" del ciborio romano di S. Paolo f.l.m., del 1285; va segnalata, però l'opinione di Keller (1934), secondo il quale proprio la menzione di P. - caso unico nel corpus arnolfiano - escluderebbe la sua appartenenza alla bottega. Se in passato nel 'socio' è stato visto Pietro Cavallini (Vertue, 1779; Moreschi, 1840) - che per alcuni studiosi dei secc. 18° e 19° è anche il Petrus di Westminster (Vertue, 1779; Walpole, 1888) - la maggioranza della critica, a partire in via ipotetica da Rossi (1889) e con certezza da Muñoz (1921), riconosce P. in modo più o meno deciso nel collaboratore di Arnolfo, sulla base dell'omonimia e della massiccia decorazione musiva presente nell'opera. Tuttavia, se da un lato il termine 'socio' sembra indicare un rapporto pressoché paritario tra i due artisti, dall'altro il maggior rilievo dato al nome di Arnolfo potrebbe contrastare con la fama che P. doveva avere acquisito in quanto autore di un sepolcro papale (se non addirittura attivo per la casa regnante inglese). È comunque difficile, all'interno del ciborio, in cui oltre ai due artisti furono attive le rispettive botteghe (Romanini, 1969), distinguere le parti che sicuramente spettano al collaboratore (Keller, 1934-1935; de Francovich, 1940; Romanini, 1969; 1983) e ancor più confrontare queste con l'unica opera pervenutaci dell'artista e cioè con la figura giacente di Clemente IV, che è evidentemente un unicum.L'ipotesi di una collaborazione tra Arnolfo e P. è stata estesa ad altre opere quali il monumento funebre di Guglielmo De Braye nel S. Domenico di Orvieto, realizzato da Arnolfo nel 1282, e quello (certo non arnolfiano) di Adriano V nel S. Francesco alla Rocca di Viterbo.A Viterbo, nella stessa chiesa di S. Francesco, è invece molto probabile che sia da attribuire a P. il monumento funebre del prefetto di Roma Pietro di Vico (m. nel 1268), oggi collocato nella parete interna ovest del transetto sud, ma un tempo situato, come quello di Clemente IV, in S. Maria di Gradi. L'affermazione che l'autore del sepolcro sia lo stesso del monumento papale, presente già nelle fonti più antiche (Papebroch, 1688; Salmini, Cronologia; Bussi, 1742), è stata generalmente accettata dalla critica e sembra confermata dall'analogia della struttura dei due basamenti. Tuttavia lo stato di frammentarietà in cui il monumento è pervenuto rende impossibile uno stringente confronto stilistico (D'Achille, 1996).Il ricordo di un'epigrafe con il nome Petrus Oderisius ha consentito di collegare a P. il monumento funebre del conte Ruggero d'Altavilla (m. nel 1101) e di sua moglie Eremburga nell'abbazia della SS. Trinità di Mileto in Calabria. Di esso sopravvive solo un grande sarcofago, che secondo la tradizione locale costituiva l'originaria sepoltura di Ruggero, conservato dal 1845 nel Mus. Naz. di Napoli. Tuttavia, nulla si può dire sulla datazione e sull'aspetto dell'opera, sommariamente descritta da Calcagni (1699) come collocata inter duas marmoreas columnas, seriamente danneggiata dal terremoto del 1659, ricostruita nel 1698 e definitivamente distrutta, con l'intera abbazia, dal terremoto del 1783. Da una pianta della chiesa di Ottavio Micosanto, del 1581 (Roma, Pontificio Collegio Greco, ACG, vol. 83, f. A), si ricava solo che il sarcofago era poggiato al muro a metà della navata laterale sud (Claussen, 1987). L'iscrizione che riferisce il nome dell'autore - oggi perduta, ma ancora esistente nel sec. 18° e trascritta da numerose fonti del tempo (Negri Arnoldi, 1972) - era secondo Cimaglia (1762) in due anelli concentrici, all'esterno dei quali nome e titolo del defunto figuravano in riquadri cruciformi (tale testimonianza sembra confermata dall'incisione inserita in Relazione, 1783, che dà notizia del ritrovamento del sarcofago del conte Ruggero) e recitava "Hanc sepulturam fecit Petrus Oderisius magister Romanus in memoriam hoc quicumque leges dic sit ei requies"; la frase andrebbe integrata con quanto era inciso nei bracci della croce e cioè "Rogerii/comitis/Calabriae et/Siciliae".La supposta presenza di P. a Mileto ha indotto Negri Arnoldi (1972) a ipotizzare un'attività dell'artista nel Meridione, individuabile, seppure in via congetturale, nel monumento funebre, oggi pesantemente alterato, dell'arcivescovo Filippo Minutolo (m. nel 1301) nel duomo di Napoli, che a suo avviso rivela alcune affinità con quello di Clemente IV (mosaici della cassa, andamento roccioso del panneggio dei giacenti, realismo dei volti). A tale attività sarebbero da collegare sia il diffondersi dell'influsso arnolfiano in questi territori sia quello di influenze meridionali a Roma. Il fatto che Filippo Minutolo fosse presente a Viterbo nel 1271, quando era in costruzione la tomba di Clemente IV, e che il suo monumento mostri punti di contatto anche con il sepolcro di Guglielmo De Braye potrebbe rendere l'ipotesi dello studioso in qualche modo verosimile. Di minor conto sono invece altre attribuzioni a P. avanzate in passato dalla critica.Anche se la figura di P. risulta ancora per tanti aspetti enigmatica, si può concordare con Claussen (1987) quando afferma che si tratta di uno dei più importanti artisti romani del sec. 13° e che la sua opera è espressione della radicale trasformazione dell'opus Romanum in opus Francigenum.
Bibliografia:
Fonti inedite. - F.M. Salmini, Cronologia Gradensis seu Conventus Sanctae Mariae ad Gradus de Viterbio (ms. del 1706), Roma, Arch. Generale Domenicano, XIV, Lib. C, parte I.
Fonti edite. - Building Accounts of Henry III, a cura di H.M. Colvin, Oxford 1971; D. Papebroch, Conatus chronico-historicus ad Catalogum Romanorum Pontificum a S. Petro ad Innocentium XI, in AASS Propylaeum Maii, 1688, pp. 53-55; D. Calcagni, Historia Chronologica brevis Abbatiae Sanctissimae Trinitatis Mileti, Messina 1699 (rist. in G. Occhiato, La Trinità di Mileto nel romanico italiano, Cosenza 1994, pp. 244-249); F. Bussi, Istoria della città di Viterbo, Roma 1742; N.M. Cimaglia, Della natura e sorte della Badia della SS. Trinità e S. Angelo di Meleto, Napoli 1762; G. Vertue, Account of Edward the Confessor's Monument, Archaeologia 1, 1779, pp. 32-39; Relazione della Commissione della Reale Accademia delle Scienze di Napoli, Napoli 1783.
Letteratura critica. - L. Moreschi, Descrizione del tabernacolo che orna la confessione della basilica di S. Paolo sulla via Ostiense, Roma 1840; H. Walpole, Anectodes of Painting in England with some Account of the Principal Artists, London 1888, I, p. 16ss.; G. Rossi, Ricerche sull'origine e scopo dell'architettura archiacuta. Mausoleo di Clemente IV, Siena 1889; A. Muñoz, Roma di Dante, Milano 1921; Toesca, Medioevo, 1927, pp. 206, 208-209, 863; s.v. Petrus Oderisii, in Thieme-Becker, XXVI, 1932, p. 505; H. Keller, Der Bildhauer Arnolfo di Cambio und seine Werkstatt, JPreussKS 55, 1934, pp. 205-228; 56, 1935, pp. 22-43; A. Perkins, Westminster Abbey: its Workshop and Ornaments, I, London 1938; G. de Francovich, Studi recenti sulla scultura gotica toscana: Arnolfo di Cambio, Le Arti 2, 1940, pp. 236-251; Toesca, Trecento, 1951, pp. 363-365; A. Monferini, Pietro d'Oderisio e il rinnovamento tomistico, in Momenti del marmo. Scritti per i duecento anni dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, Roma 1969, pp. 39-63; A.M. Romanini, Arnolfo di Cambio e lo "stil novo" del gotico italiano, Milano 1969 (rist. anast. Firenze 1980); K. Bauch, Anfänge des figürlichen Grabmals in Italien, MKIF 15, 1971, pp. 227-258; F. Negri Arnoldi, Pietro d'Oderisio, Nicola da Monteforte e la scultura campana del primo Trecento, Commentari 23, 1972, pp. 12-30; J. Gardner, Arnolfo di Cambio and Roman Tomb Design, BurlM 115, 1973, pp. 420-439; E. Carli, Il gotico (La scultura italiana), Milano 19742 (1967), p. 93; K. Bauch, Das mittelalterliche Grabbild. Figürliche Grabmäler des 11. bis 15. Jahrhundert in Europa, Firenze-Berlin-New York 1976, pp. 141-153; A.M. Romanini, Arnolfo e gli "Arnolfo" apocrifi, in Roma anno 1300, "Atti della IV Settimana di studi di storia dell'arte medievale dell'Università di Roma 'La Sapienza', Roma 1980", a cura di A.M. Romanini, Roma 1983, pp. 27-72; I. Herklotz, "Sepulcra" e "Monumenta" del Medioevo. Studi sull'arte sepolcrale in Italia, Roma 1985 (19902); M. Mercalli, Arnolfo di Cambio e ''socius Petrus'', Ciborio (1285), Roma, S. Paolo fuori le mura, in Roma 1300-1875. La città degli Anni Santi. Atlante, a cura di M. Fagiolo, M.L. Madonna, cat. (Roma 1985), Milano 1985, p. 72; A.M. Romanini, Il ritratto gotico in Arnolfo di Cambio, in Europäische Kunst um 1300, "XXV. Internationaler Kongress für Kunstgeschichte, Wien 1983", VI, WienKöln-Graz 1986, pp. 203-209; P.C. Claussen, Magistri Doctissimi Romani. Die römischen Marmorkünstler des Mittelalters (Corpus Cosmatorum I) (Forschungen zur Kunstgeschichte und christlichen Archäologie, 14), Stuttgart 1987; A.M. D'Achille, Sulla datazione del monumento funebre di Clemente IV a Viterbo: un riesame delle fonti, AM, s. II, 3, 1989, pp. 85-91; id., Il monumento funebre di Clemente IV in S. Francesco a Viterbo, in Skulptur und Grabmal des Spätmittelalters in Rom und Italien, "Akten des Kongresses ''Scultura e monumento sepolcrale del tardo Medioevo a Roma e in Italia'', Roma 1985", a cura di J. Garms, A.M. Romanini, Wien 1990, pp. 129-142; P.C. Claussen, Pietro di Oderisio und die Neuformulierung des italienischen Grabmals zwischen ''Opus Romanum'' und ''Opus Francigenum'', ivi, pp. 173-200; J. Gardner, The Cosmati at Westminster: some Anglo-Italian Reflexions, ivi, pp. 201-216; P. Binski, The Cosmati at Westminster and the English Court Style, ArtB 72, 1990, pp. 6-34; J. Gardner, The Tomb and the Tiara. Curial Tomb Sculpture in Rome and Avignon in the Later Middle Ages, Oxford 1992; A.M. D'Achille, Le sepolture medievali, in Santa Maria di Gradi, a cura di M. Miglio, Viterbo 1996, pp. 129-159.
[Da: http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-di-oderisio_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/ ]